Il lavoro è una necessità, oltre che concreta e materiale, anche spirituale. Chi ne è attivamente cosciente è già un uomo libero. Ma attenzione, il grande filosofo tedesco Hegel utilizzava una parola per indicare questa coscienza che includeva la nozione non solamente di conoscenza passiva ma anche di volontà applicata e conseguente. È forse in questa accezione di coscienza attiva e coerente che consiste l’ammirazione oscura dei meridionali per una quasi segreta ed incoffessata superiorità razionale, tipicamente settentrionale: tedesca, per l’appunto. Non basta avere la consapevolezza, per esempio, del Bene, bisogna perseguirlo. La coscienza della necessità porta alla libertà, è la libertà stessa, se questa “coscienza” è operativa. I meridionali hanno tendenza a separare la coscienza della conoscenza dalle sue conseguenze logiche e ragionevoli: altra è la ragione e altra la sua applicazione, di fatto dicono. Così essi giungono a crogiolarsi e vantarsi della loro cosiddetta capacità speculativa anche ben separata e divorziata dalla intrinseca sua operatività.
Sono nato nel meridione italiano, in Abruzzo sul mare Adriatico e all’altezza di Roma, e ci sono rimasto fino alla terza elementare: ne parlo ancora oggi il dialetto! E questo, fino a quando i miei genitori si son trasferiti in Lombardia, in Alta Italia come si diceva allora, sul Lago di Varese, con vari parenti anch’essi immigrati che lavoravano nella confinante Svizzera. Ho potuto così guardare tutta la mia vita, attraverso la parte della famiglia rimasta in Abruzzo e quella emigrata nel settentrione estremo dell’Italia, la doppia natura vissuta di questa parola che costituisce il baricentro della famosa definizione hegeliana “La libertà è la coscienza della necessità”.
Dopo che con mia moglie, di famiglia integralmente milanese da molte generazioni di cui sono stato il primo intruso di origine meridionale, ci siamo traferiti in Belgio, nell’estremo settentrione continentale da quasi quarant’anni (vi abbiamo vissuto più che in Italia), abbiamo commentato insieme un episodio molto emblematico: il suo collega funzionario all’Unione Europea, italiano molto meridionale, se n’è uscito con una frase simbolica e rappresentativa della cultura detta al nord “terrona”: “A voi milanesi piace lavorare: allora lavorate! A noi del sud, invece, piace essere cultura: noi siamo la civiltà e voi il vile denaro”…
La cosiddetta differenza di concezione esistenziale scaturigine della divisione tra civiltà e denaro, tra debitori e creditori, tra la Grecia attuale e la Germania, esprime in nuce tutta l’attualità del conflitto culturale ed economico del nostro tempo.
La spensierata gioia ad Atene dopo il referendum, nella sera danzante e di festa in piazza, misurava l’abissale lontananza – non solo in kilometri – della capovolta nozione di civiltà. Questa fissava lo scambio paradossale tra l’antica cultura mediterranea, diventata recidivamente e spudoratamente scroccona (in pratica), con l’eterna ragione razionale, contrattualmente libera e reciproca, dei paesi settentrionali. L’ideologia e il simulacro della falsificazione ha preso il posto al sud della civiltà e della grande cultura che sono, nel frattempo, passate al nord: presso coloro che erano stati definiti nella stessa Grecia, tremila anni fa, i “barbari”.
Però gli attuali paesi creditori non hanno quasi il coraggio culturale di definire chiaramente incivile e fedifraga la Grecia praticamente in default. Questa si vanta – in sostanza e implicitamente – di aver gabbato la loro fiducia per essere riuscita a farsi accordare cotanti miliardi di euro sulla promessa – naturalmente non mantenuta – del sacrosanto rimborso.
In realtà , anche i paesi creditori di Atene hanno gabbato, però, con debiti oceanici che non solo non hanno rimborsato, ma che aumentano continuamente e non hanno, come i Greci, nessuna intenzione pratica di rimborsare. Solo che questi debiti li hanno contratti unilateralmente e antidemocraticamente – cosa ancora più grave – col futuro, con le generazioni seguenti, vale a dire coi propri figli e nipoti!
L’immoralità, la stessa, è così totalmente dilagata al punto che quella greca è ora solo una piccola parte dello sfacelo europeo che toglie così tanto coraggio a tutti: mal comune nella stessa barca!
Il grande Hegel non avrebbe forse mai immaginato questi connotati della situazione attuale. Infatti egli utilizza nella sua brevissima formula filosofica tre parole: libertà, coscienza e necessità con un senso certo. Oltre alla radicale ambiguità del termine “coscienza” (che i meridionali – ma ormai non solo – interpretano sempre esclusivamente e svergognatamente in modo avulso e mistificato dalla sua operatività), anche “libertà” e “necessità” non vogliono ora più univocamente significare lo stesso senso dell’epoca del filosofo (fine settecento). A quel tempo, la concezione del mondo era ancora sostanzialmente religiosa. La fede, generalmente indiscutibile e indiscussa in Dio (siamo solo alla vigilia o agli inizi molto elitari della secolarizzazione miscredente!) faceva sì che queste due parole (libertà e necessità) avessero tutto il loro senso ontologico e non quello relativistico, soggettivo e spappolato dei nostri giorni.
Anche il lavoro, quindi, non è più ora una verità univoca della fattualità e dello spirito.
Quando non si crede più in Dio, tutto diventa possible e incerto. La sola certezza è che tutto diventa relativo e psicologistico. La follia e l’irrazionale assurgono a regola nella quale si è impigliata la ragione.
Quaerere Dominem (Cercare Dio), diceva Benedetto XVI a Parigi. Lavorando in piena coscienza!
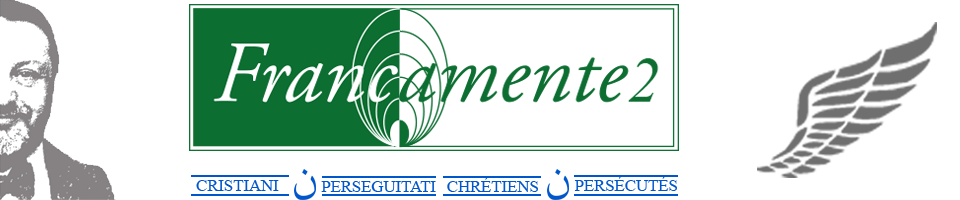
Laisser un commentaire